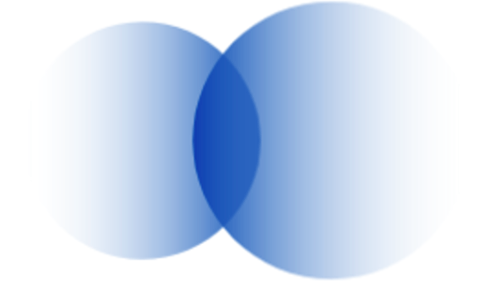Si riportano di seguito le riflessioni di Giocchino Vaiano, preside, maestro, collega e amico di Giovanni Ferrari. Vaiano ha condiviso con Ferrari anni d’insegnamento a Nemoli e, successivamente, un sodalizio intellettuale e personale durato tutta una vita. Dopo anni dalla morte di Ferrari, Vaiano ritorna sull’essenza della poesia dell’autore lucano in un pamphlet intitolato “Per sempre ricordare. Giovanni Ferrari: poeta del Sud“. Si tratta di un attestato di affetto e di stima che vuole ricordare ai posteri il valore e la potenza dei versi di Ferrari. Ferrari poeta del Sud, finalmente accostato alle più alte voci del Sud che hanno cantato le pene e le umiliazioni degli straccioni, dei cafoni, dei terroni. Ferrari meridionalista, vicino a Salvemini, Rossi Doria, Scotellaro, Dolci, che denuncia il sottosviluppo economico e l’egemonia culturale del Settentrione d’Italia visibile nello spopolamento dei borghi e nelle condizioni di vita degli immigrati meridionali nelle “grandi” città del Nord.
“Per sempre ricordare. Giovanni Ferrari: poeta del Sud” di Gioacchino Vaiano.

La poesia di Giovanni Ferrari non nasce per un mero esercizio retorico, non si presenta come gioco sterile di parole, ma viene da una profonda sensibilità d’animo di un affermato professionista, di un grande uomo. Ha vissuto la sua vita con entusiasmo e autenticità, fortemente radicato nella società del suo tempo, che ha trasformato con tutte le sue forze, denunciandone, nel contempo, gli aspetti negativi.
Prima di essere un poeta, Giovanni Ferrari è stato un degno figlio di Dio, legato intensamente alla famiglia, alla società del Sud e si è battuto sempre per una migliore qualità della vita.
L’impegno profuso in tutta la sua produzione poetica è in diretto rapporto con la poetica degli anni Cinquanta del secolo scorso: Giovanni Ferrari conosceva bene l’intreccio delle necessità ideologiche del tempo (come la “filosofia della prassi” e le teorie della letteratura come “impegno etico e sociale”) che approdavano alla costruzione di un verso pregnante, costruttivo, espressione di una incisiva denuncia storica.
Facciamo dei nomi: Pavese, Rocco Scotellaro, Sinisgalli, Pasolini.
Su questa nobile tradizione s’innesta la poesia di Ferrari, imbevuta di sano realismo, di motivi politici, di polemica civile, morale e storica.
“Case senza fumo”, 1978.

“Case senza fumo”, lavoro principe del nostro poeta, edito da Rizieri Editore di Lauria (PZ) (con in copertina uno splendido disegno del pittore Gianni Talamini), è un atto di “poesia civile” che procura risonanze interiori, ma che assume una dimensione molto vasta: comprende certamente il dolore per l’abbandono forzato delle terre del Sud di migliaia di nostri fratelli, ma si allarga ad un’infinita gamma di sentimenti e di riflessioni che chiamano in causa i più autentici “modi dell’essere”.
Il verso chiaro, puro, cristallino è un tutt’uno con i sentimenti espressi e anche in questa direzione, cioè nella trasformazione del linguaggio, il nostro poeta ha fatto centro: è riuscito a comunicare con un linguaggio comprensibile a tutti che colpisce subito l’animo del lettore e l’affascina.
Si presenta, l’opera, come unitaria, guidata e sorretta da un disegno e da un discorso ben definito e compatto.
La storia del poeta, nella sua Nemoli, in Basilicata – come può essere quella di una persona qualsiasi di una martoriata regione del Sud – è un tutt’uno con la storia dei suoi compaesani, con la storia di tutte le famiglie degli emigranti di ieri.
E il motivo del “grande esodo”, con le sue crudeli conseguenze, con le sue angosce, con le sue rotture interiori, che fa da motivo conduttore dell’intera raccolta.
Da “Case senza fumo”, pag. 7
Il Sirino è solo
Nel suo manto di nuvole senza buchi.
Fumano ancora i comignoli
Lungo le braccia delle quattro vie
Tra il tenero dell’erba nuova
E il verde del grano
Che prende coraggio
Giorno per giorno.
Tante case – però – non hanno più fumo
E tanti casolari
Giorno per giorno consumano
La speranza di essere riaperti
Coi calcinacci che rotolano
Dagli stipiti contorti dalla pioggia
Dai soffitti di ragnatela
Dai nidi dei topi migranti la notte
Tra le radiche
Dei vecchi olivi infolloniti
Nel campo accampo fitto di rovi
Che ha dimenticato l’aratro.
Dall’alto dell’orizzonte
Nella nuvola bianca
Che a Pasqua naviga il cielo nuovo
La schiera dei vecchi padroni
Ritrova tra gli sterpi la vecchia casa
Quasi sepolta
E lega col filo della memoria immobile dei morti
I mille ricordi della loro vita
Che fanno la storia di tutte le case del mio paese
Che non hanno più fumo.
L’eco del silenzio
I nostri sogni impossibili
sfumano ad ogni alba spietata
con la sua luce di ghiaccio
nata a mettere a nudo
le nostre miserie immobili.
Ora
il nostro messaggio
è l’eco del silenzio sterile
del nostro dolore senza senso
l’amaro delle nostre lacrime
diventate pietre
nel vuoto del nostro cuore rassegnato
colle speranze mute
inchiodate a una a una
nel muro piatto del nostro domani.
Siamo troppo poco.
Solo un fiume senz’acqua
e la cresta di un monte senza alberi
disegna la nostra identità.
La nostra miseria
non è degna di note
e qualcuno ci ha detto
che non siamo neppure terra
e che è inutile parlare.
Nella bocca
incapace di dire
svanisce
la pretesa di essere ascoltati.
“Case senza fumo” è anche un titolo emblematico per definire la realtà negativa di quel tempo nelle nostre terre del Sud: abbandono, nostalgia, sofferenze, attese lunghe e logoranti! Le donne del Sud!
Da “Grazia Maria” (Pag. 14)
Tu piangi Grazia Maria
Sono passati già dieci giorni
Dall’ultima lettera…
Tu pieghi gli occhi di cerva
Inghiottendo la luce del giorno.
Socchiudi l’imposta in attesa.
Tu trepida Grazia Maria!
Per chi annodi
I lunghi capelli lucenti
Al ramo di rosa di maggio
Grazia Maria
Se Natale è ancora lontano?
Primavera è scoppiata
Solo da un mese
Nei campi di fiori
E il cuculo canta ancora
Tra le foglie nuove dei salici
Conta i singhiozzi del cuculo
Grazia Maria…
Sono tanti i singhiozzi del cuculo
E gli anni pure sono tanti…
Per chi ti vesti a nuovo
Come la primavera
E ti profumi il seno acerbo di sera,
Grazia Maria?
E come non commentare la triste agonia della fanciulla innamorata, protagonista de “La barca delle fate”? Dopo tanti sogni, dopo anni di trepidazioni e sofferenze, la fanciulla si era preparata ad accogliere il fidanzato che era partito per arricchirsi e con la promessa del matrimonio!
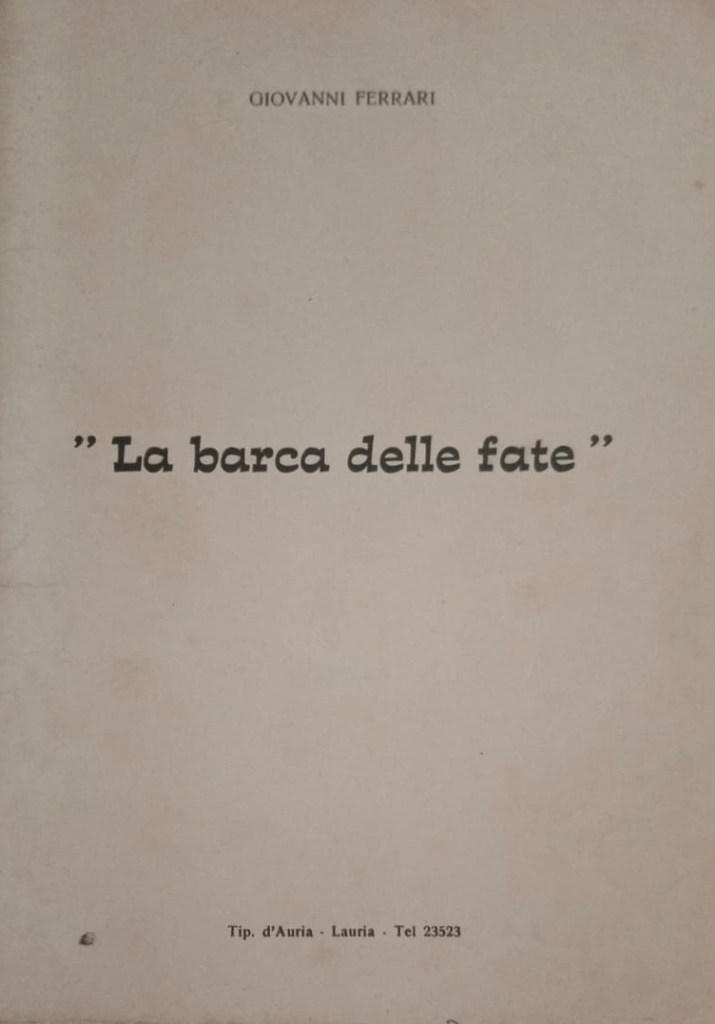
Da “La barca delle fate”:
Tesseva alla finestra sempre aperta
La fanciulla nel giorno d’estate:
in un a nuvola di polvere lontana
in fondo allo stradone solitario
lo riconobbe tra i raggi del sole.
Corse a mettersi l’abito più bello
Intrecciò le lunghe trecce brune
Ai fiori rossi della siepe dell’orto
Corse alla porta ad aspettare
Con lo scialle vermiglio sulle spalle.
Apparve
Cavaliere con cavallo
Vestito a festa come un galantuomo.
Gli gridò la fanciulla: Bentornato!…
Ed egli andò via senza guardarla.
Si chiuse la finestra sulla strada,
tacquero la spola e l’arcolaio;
si spense lento il fuoco del camino.
La fanciulla fuggì lontano,
verso il mare,
verso il sole e gli scogli di marina.
Annotazioni
Nell’anno scolastico 1974/1975, “La barca delle fate” fu rappresentata con molto successo – nell’aula magna (ex-vescovile) della scuola media di Policastro Bussentino – dagli alunni della seconda e terza media.
Erano presenti alla “drammatizzazione” – ideata da Gioacchino Vaiano – :
- l’autore del poema, Giovanni Ferrari, Direttore didattico della scuola elementare di Via Crispi (ora scuola verticalizzata Dante Alighieri) di Sapri;
- il preside, prof. Giuseppe Campanaro;
- tutti i docenti della scuola media di Policastro;
- i genitori degli alunni;
- il prof. Mario Carpentieri, docente di religione e parroco di Policastro;
- S.E. Vescovo emerito, Federico Pezzullo, della diocesi di Policastro Bussentino, per il quale è stata già avviata la causa di “beatificazione”.

I nostri fratelli sono fuggiti in cerca di terre nuove e per non essere esposti ai ritmi ciclici di una natura, a volte ostile, come in Basilicata e nel Sud.
Da “Tu mi hai detto” (Pag. 40):
… Ho visto mio fratello
lottare col fiume
in gara disperata con le frane
per difendere l’ultimo lembo
della terra di mio nonno,
… Ho visto mio fratello
spiare l’arrivo del padrone
lasciare a pezzi la sua anima
nella cava di pietra arsa con la fornace
e mio padre
dall’alto dei suoi settant’anni
contare nel palmo
i pochi chicchi
della spiga nuova del nostro campo…
Da “Piaghe” (in Frantumi di Nuvole), (Pag. 28):
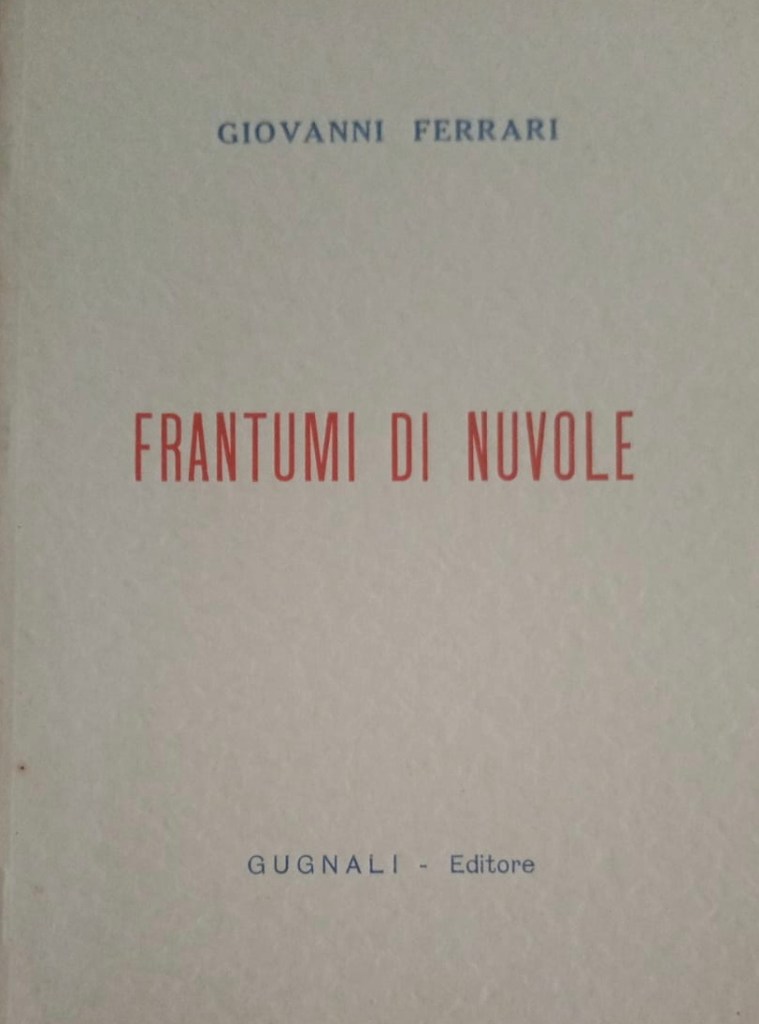
Il mio Sud…
Com’è povero con i suoi rigagnoli
Rifatti fiumi assurdi
Dalle ultime piogge
Coi suoi spettri silenziosi
Che svaniscono nelle frane scoscese
Colle pietre biancastre
Che mettono fuori le crepe profonde
Come ferite
Che guariscono con le tempeste.
Ma al Nord i nostri fratelli cosa hanno trovato?
Realtà estranee, situazioni mai conosciute, vita da ghetto…
Cosa hanno perso, lontani dalle loro radici?
“Quando l’animo umano perde le sue qualità, nessuna analisi riesce a misurarlo!”
Giovanni Ferrari è andato a trovarli i suoi fratelli,
è andato in pellegrinaggio al Nord, quasi per ripercorrere il calvario della loro sofferenza!
Ha preso “il treno del sole” e così dice:
Da “Il mio paese” (Pag. 17):
Io li incontrai
In una notte milanese
I suoi figli più giovani
Il suo sangue più vivo.
Erano della mia età
E delle classi più giovani
E negli occhi avevano ancora
Il cielo dei nostri giochi
E nelle orecchie
Lo zirlio dei merli in amore
A primavera
Col grido sordo
Dei nostri fiumi.
Li incontrai tutti
In una notte milanese.
Erano con le mogli e i figli
Dalle parole troppo diverse
Mozze dall’affanno di far presto
Per sentirli nostri.
Un’angoscia indicibile prende il poeta e lo gela, quando, dalla lettura del giornale, rileva che i fratelli del Sud muoiono per incidenti sul lavoro.
Da “I terroni” (Pag. 18):
io non li conoscevo
ma sul giornale
avevano lo stesso mio volto
la stessa faccia
dei miei fratelli del Sud.
Erano della mia terra
Di uno dei suoi tanti paesi
Che muoiono ogni giorno di più
Seminando goccia a goccia
Il loro sangue.
Io non vi conoscevo
Ma il vostro volto
Era lo stesso mio volto
E il vostro dolore
Il mio stesso dolore
Voi che la nostra terra
Ha mandato a morire
Da chi non ha bisogno di morire
Per mangiare
Io che sono rimasto
A morire ogni giorno un poco
Con voi che morite lontano.
Nella vecchia casa
Calcinata del sole troppo lucente
La mamma
Spolvera il vecchio scialle stinto
Nero del suo dolore
E della nostra miseria.
Che dice il nostro poeta della triste realtà dei giovani emigrati che restano abbacinati dalle luci della città, del benessere, usano la violenza, lasciando la retta strada perché non sentono più le “radici”?
Da “Mio fratello più giovane”:
È dietro le sbarre
Dei riformatori del Nord
Mio fratello più giovane:
È avaro di sorrisi il Nord
Come la nostra terra di grano.
È avaro di sorrisi il mondo
Per chi ha bisogno.
Nessuno ci tende la mano amica.
Raccattiamo le briciole
Nell’indifferenza dei bocconi dei sazi.
Quando ci mettono dentro
Per redimerci
Diventano tutti pietosi.
Hanno riempito
Le celle dei riformatori
Di Lombardia e Piemonte
I miei fratelli più giovani.
Li avevamo mandati
Analfabeti e innocenti da loro
Col nostro sole negli occhi
Con nel cuore
Il canto dei merli in amore
E il pigolio dei nidi nascosti.
Con il ricordo della prima serenata
Al chiaro di luna
A una acerba Maria
Col rumore dei nostri fiumi
Fatti arditi dalle piogge d’autunno
Negli orecchi
Cresciuti al ritmo di nenie infinite.
Allucinati e delusi
La loro ignoranza innocente
Hanno sacrificato
Nell’abbraccio torbido
Di una di loro:
hanno smarrito
l’azzurro del nostro cielo
inchiodato pezzo a pezzo
nei loro occhi
nelle sere d’estate.
È il rimpianto del “passato” che si manifesta con forza nella poesia di Giovanni Ferrari.
Le sue liriche manifestano e denunciano un malessere corrosivo che, nel suo caso, si fa chiarezza e coscienza e mai nevrosi o – peggio ancora – morte interiore.
È il trauma del passaggio dalla civiltà contadina alla civiltà industriale, avvenuto repentinamente e vissuto, altresì, come negazione della propria identità.
La fabbrica con i suoi ritmi ossessivi – nonostante tutti i processi di trasformazione del rapporto operaio/padrone – resta un cancro sociale, soprattutto quando alle spalle e nei cuori degli uomini ci sono primavere all’aperto, il germogliare delle piante, il mistero delle stagioni!
E il cuore del nostro poeta si dilata, assume in sé tutti questi problemi e crea immagini meravigliose sulla natura e sulla civiltà contadina. Versi splendidi compone Ferrari, che trovano l’equivalente solo nelle tele del grande pittore di Torraca, Biagio Mercadante, e dell’altrettanto grande pittore di Sapri, Nemoli e Padova, Gianni Talamini.
Annotazioni
Biagio Mercadante, pittore nato a Torraca, ha vissuto e lavorato a Torraca, Napoli, Sapri. Nell’estate del 2009, il Comune di Torraca, nel suo caratteristico centro storico, ha disposto un’installazione a scala urbana dei dipinti del maestro.Un progetto realizzato anche con l’utilizzazione “delle nuove tecnologie a Led” – per l’illuminazione notturna dei quadri – che ha dato il giusto valore alla produzione artistica di Mercadante (dall’opuscolo “Biagio Mercadante”, 2009).
Gianni Talamini, pittore e scrittore, nato a Sapri, ha vissuto e lavorato a Padova e a Sapri. Il 10 agosto 1998, il Comune di Nemoli, per la prima volta nella sua storia, ha concesso al maestro, la cittadinanza onoraria e le chiavi della città. Talamini ha allestito mostre personali in Italia e all’estero, ha preso parte a numerosissime collettive, ha scritto e pubblicato romanzi e racconti (dal romanzo “Pietro” di G. Talamini, 1999, Ed. Kairos).
Da “Le due speranze” (Pag. 44)
Il vento ci porta il profumo del mare
Il sussurro del bosco pulito
La voce del fiume fatto più ricco.
…
Raccoglie le nuvole
L’ultimo velo di vento
E l’ultimo raggio del tramonto
Brilla nell’azzurro tenero
Tinto nel cielo per un miracolo nuovo.
Da “Le lucciole” (Pag. 46)
Si inseguono al chiaro di luna
Sul grano che spiga
Singhiozzi di luce.
È scesa la sera di maggio
Sulle case brune tra i campi in fiore
Nel canto d’amore dei grilli.
Impazzano le lucciole
Sul fondo scuro dei monti.
Da “Grande città” (Pag. 32)
…
A me bastano ancora
I miei prati rosi dalle frane
Ricchi di sole e di grilli
Dove ruzzolando
I bimbi imparano a camminare
E il capretto di marzo
Grattando la scorza dei pini
Prova le corna appena spuntate
Dove un fiordaliso è un occhio di cielo
E una primula senza colore
Porta il messaggio della primavera anzitempo
E il pettirosso
Nel cespuglio del calanco
Sverna i suoi giorni di freddo e di malinconia
Con la fame del gatto
Che insegue il suo volo.
…
Da “Inverno 73”:
…
Nevica ancora
Dopo tutta la neve di stanotte.
Scompare lo sporco del sottobosco
Al pulito nuovo dell’ultima falda.
Inchiodano i cristalli del cielo
Sul fondo di latte
I rami nudi del querceto
In un gioco di neri graffiti.
Da “Mio fratello più giovane” (Pag. 8)
Schiaccia il sole di prima estate
Le colline
E i campi d’oro
Già pronti alla falce
Inclinano al vanto di giugno
Le spighe ricolme.
Arrota
Mio padre
Sotto la pergola di una puttanella
Che conta già i chicchi
La falce azzurrina
E dalla cassa nera
Spolvera il lungo grembiule di capra
Coi ditali aguzzi di canna.
Già a S. Giovanni
Si miete da noi
Ma quest’anno l’estate è tardiva
E sarà S. Pietro a benedire
Le falci roventi.
…
Passa tra i mietitori
Il prosciutto nuovo
Col vino della botte più grande
Alla prima mattina
E l’acqua è dolce nel campo di sole
Nella gerla di creta
Dal collo sottile.
Da “Mietitura” (Pag. 41)
Brilla nell’oro del grano,
gocce calde su sottili vene verdi
stillate col sudore
delle mani di mio padre
aperte a propiziare
l’amplesso dell’aria e del cielo
alle zolle arate col seme d’oro
il rosso dei papaveri.
Giugno caldo
Passa la falce
Rilucente rasoio bruciante
Su un volto glabro vizzo di stagioni
Arido di umori seccati da tante bocche
Lungo tutte le estati del tempo.
Il sangue di mio padre
Quello di suo padre e dei miei,
generazioni passate in corsa
lungo le vie inutili
della nostra povera storia,
vite lontane calcinate
negli aridi labirinti
di un lento passato dimenticato,
spunta puntuale ad ogni giungo
come sangue di stimmate
al venerdì santo
scavate da sempre
come in quella di Cristo
nella carne degli uomini della mia terra.
Respira fuoco
Col fiato di vino e tabacco
La collina ormai rasa.
Nel pomeriggio di prima estate
L’ombra invita
All’ultima chiazza di verde!
Con questa ultima lirica siamo entrati “nel regno degli affetti domestici”: l’amore per la madre, per il padre, per i fratelli, per i nonni, per la moglie e i figli.
“La religione degli affetti” è una componente essenziale dell’arte di Giovanni Ferrari e traspare da tutte le sue raccolte più importanti.
“Frantumi di nuvole” (1967)
“Natale” (1968)
“La barca delle fate” (1973)
“Case senza fumo” (1978)
Ferrari alza alto il canto dell’amore per la famiglia che diventa il tempio in cui i sentimenti più veri e più puri vengono conservati e preservati dall’incalzare inesorabile di una pseudo-civiltà che tende a mortificare tutti i valori.
La mamma diventa in “Natale” una sacerdotessa e tutte le sue azioni e parole hanno il crisma della sacralità.
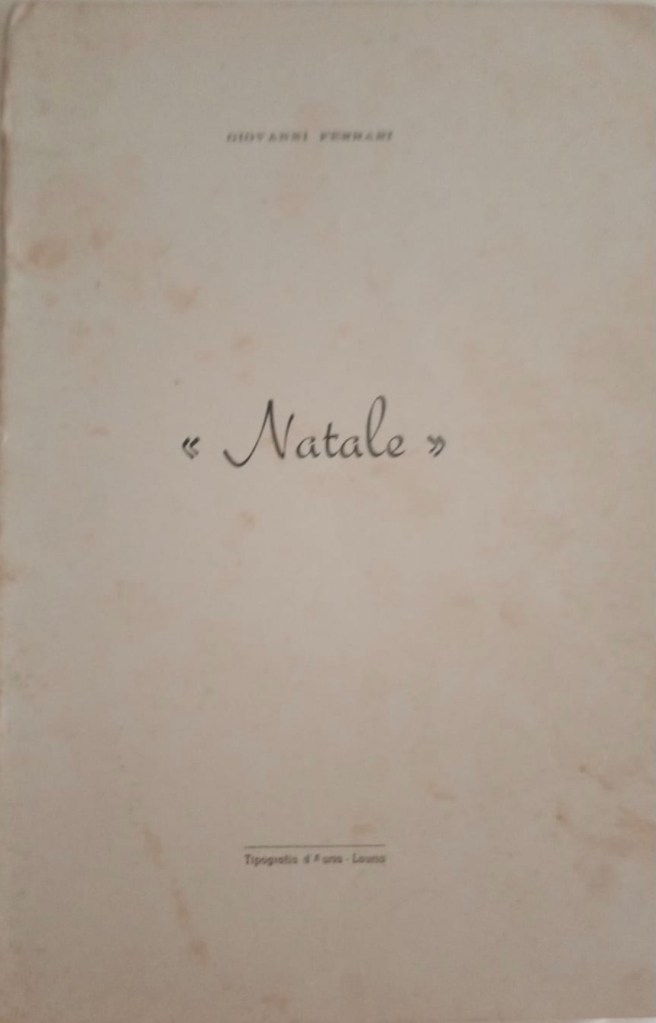
Da “Natale” (Pag. 9)
…
La mamma ha posto nel piatto grande
Le ciambelle più belle
E mio padre è sceso verso l’unica botte
A spillare un poco del vino nuovo.
Poi andremo a dormire.
Se verrai stasera
Anche tu, caro amico mio,
potrai berne
e potrai gustare
il dolce del miele dell’arnia dell’orto
e mia madre sarà felice
di vederci bere insieme
e leccare il residuo di dolce
sulla crosta dorata del fritto
e vorrà che tu beva ancora
il dolce boccale di fango
sarà riempito più volte per te
perché oggi è festa
e noi ci vogliamo bene.
Se poi vorrai
Farà fiorire il bianco granturco
Nella padella rovente
E su quei fiori
Il vino sarà ancora migliore.
E ti dirà
Che così facevano i nostri padri
E dovranno fare i nostri figli.
Con la madre, Ferrari, ha un vecchio debito di riconoscenza e le ha innalzato un monumento nella lirica “Mia madre”, tratta dalla raccolta “Frantumi di nuvole” (Pag. 8):
Ha atteso che la morte mi sfiorasse
Per schiarirsi la voce dal pianto,
le sue lagrime
mi hanno rivelato il suo amore…
nell’ansia di rivedermi vivo
ha smarrito la speranza
e la sua fede immobile
ha osato patteggiare con Dio
e gli ha detto: “È mio figlio!…”
L’ultima lacrima muta
Ha detto tutto il suo affanno:
ore insonni
nell’ansia di novità temute
nella speranza del risveglio,
preghiere a fior di labbra
sussurrate senza scendere al cuore.
Il suo grande dolore
Compreso nel suo pianto sterile
Tutto contenuto nei suoi sospiri
S’è spento nella penombra grigia
Di un triste abat-jour…
E il nonno!…
Questo personaggio vivo, vero, umano, di cui tutti andremmo fieri ed orgogliosi per la serietà e l’impegno profuso nel gestire “la cosa pubblica”, per il suo comportamento originale, che lo rendono tanto simpatico ai nostri occhi.
Da “Mio nonno” (Pag. 48)
Era tornato a fare il contadino
Mio nonno
E l’avevano fatto sindaco.
Dei trent’anni d’America
Gli restava il vestito buono della festa
E il cappello messicano
Con la vigna e la casa da finire.
Qualcuno rideva di mio nonno
Sindaco contadino
Quando la sera
Al ritorno dalla terra
Saliva al municipio
A firmare le carte.
E legava l’asina
Vecchia di molte figliate
All’albero d’acacia
A destra della casa comunale.
Qualcuno rideva
Ma tutti gli volevano bene
E vollero che facesse il sindaco
Per più di vent’anni
Perché era onesto e parlava con loro.
Un giorno
Quando gli dissero di vestirsi di nero
Per andare dal Prefetto
E di lasciare il vestito
Che gli ricordava l’America,
egli che non capiva certe cose
non volle più fare il sindaco.
Gli vollero bene
Perché non aveva preso neppure una carta
Non sua.
E quando fecero la strada nuova
Non volle che passasse per la sua terra
Lontana un’ora da casa
Perché nessuno potesse dire
Che vi poteva arrivare in carrozza.
E quando dovevano fare la nuova guardia
Chiamò suo figlio
Sull’aia sopra la casa del colono
E gli indicò la distesa del podere
E gli mise nel palmo
Un pugno di terra bruna
E gli disse che aveva tanta terra da zappare
E gli altri non avevano tanta
Ed era bene che mettessero il cappello nero
Che aveva già comprato col fregio.
Tutti gli vollero bene
E quando se ne andò
In un giorno freddo di dicembre
Che il vento tagliava la faccia
Se ne andò in punta di piedi
Senza la bandiera del comune
E la corona di fiori e di lauro
Ma con tanta gente
Che gli piangeva intorno.
Qualcuno rideva
Di mio nonno sindaco contadino
Ma molti lo piansero sinceri
E tanti ancora ricordano come parlava
Perché parlava semplice
Con la lingua della sua gente
E tutti lo capivano.
In un altro giorno freddo di dicembre – ma nel 1977 – l’amicizia profonda che mi ha sempre legato al poeta (da quando, nel 1967, l’ho conosciuto a Nemoli e l’ho apprezzato come collega e vice-preside nella scuola media che, allora, era sezione staccata della media di Rivello) mi ha riportato nel suo paese natale per porgere l’estremo saluto ad un altro uomo pianto da tutti: era papà Ferrari che, dopo una vita onesta e laboriosa, percorreva la strada celeste da Nemoli all’eternità!
Da “Natale” (Pag. 8)
…
Accanto al cane
Appoggiato all’alare
Del vecchio camino
Attende il ceppo più grande
Della nostra legnaia.
Mio padre
Con me e mio fratello
Lo porrà accosto al muro nero della cappa
E mia madre e mia sorella
Ci vedranno compiere il rito
E ci baceranno
Augurandoci cent’anni di vita felice.
Ora
Il fuoco brilla di nuovo
E noi abbiamo detto le preghiere
In ginocchio
E ci siamo baciati!
Anche il padre, come la madre, è presentato dal nostro come un sacerdote “della religione degli affetti” nell’esercizio delle sue funzioni sacrali! “L’elegia a mio padre” – nell’appendice a “Case senza fumo” – è una testimonianza imperitura di affetto di un figlio amorevole oltre misura.
Da “Elegia a mio padre” (Pag. 58)
Padre mio, dolcissimo…
Le tue mani santificate dal lavoro
D’ogni giornata tanto lunga
M’hanno benedetto tante volte
Come il sole di mattina
E la tua bocca nei discorsi senza pretese
M’hanno detto tutta la verità del mondo:
la sapienza degli umili;
la sapienza di tutti i nostri vecchi.
Nella nostra miseria felice
Colla speranza di un mondo più buono
E il sogno di gioie mai provate
Ho imparato con te
Il mestiere di uomo del mondo
Senza invidie e senza pretese
Con l’arte di amare
Che non conosce il ricambio.
Questi motivi personali, intimi sono vissuti da Ferrari in un contesto sociale, in una realtà umana ben precisa e perdono i connotati di “diario intimo”.
Il poeta, impegnato anche politicamente nel Mezzogiorno, non si ferma, però, alla denuncia, ad indicare devastazioni e vuoti di un tipo di trasformazione della nostra società in quegli anni difficili della nostra storia. Se si fosse fermato ad indicare solo i mali, la sua poesia sarebbe risultata vuota, sterile, a caccia di miti e nulla più! Ferrari, invece, è cosciente che il Meridione italiano ha mutato segno ed aspetto: non è più il problema della miseria meridionale, non più il discorso delle aree depresse, ma è il discorso della completa utilizzazione delle risorse. È un problema di espansione e di destini futuri, che deve fare i conti con quello che resta nel Sud, con il ritorno degli emigranti e di quanti non intendevano più partire!
Così la “questione meridionale” riappare autenticamente come questione nazionale ed europea: questione per la quale occorreva impostare programmi nuovi, compiere scelte definitive, prendere gravi e importanti decisioni! Tutto è avvenuto puntualmente e a distanza di alcuni decenni da allora, è sempre valida l’ipotesi di Giannino Ferrari sulla strada da percorrere per far fronte all’incalzare inesorabile dei tempi nuovi!
Da “La mia grande città” (Pag. 30)
…
No.
Non voglio
Una grande città
Con le piazze troppo grandi
Piene della luce gelida dei neon
Dove solo con la mia ombra
Perdo il mio urlo di uomo solo
Nel silenzio senza eco
Senza speranza
Che qualcuno lo senta
…
Che me ne farò
Della mia grande città
Se non ci sono gli amici
Che gridano il mio nome pulito
Senza “signore” o “dottore”
Se mi sento lontano
Dagli uomini
Che mi stanno vicini
E che non ho tempo di conoscere.
…
Ma se ci foste voi
Che siete cresciuti con me
Quando di noi ce ne erano tanti
E che siete andati via.
Se ci foste voi
Con le vostre donne e i vostri figli
E pensassimo insieme
A costruire una grande città.
Pure senza sole e senza luna
Pure senza fiori e senza voli
Allora sì
Allora volentieri
Anch’io ci starei!
L’itinerario poetico percorso insieme ci ha condotto a mettere in luce il messaggio profondo e significativo dell’arte di Giovanni Ferrari: costruire tutti insieme, con amore, “la grande città”, simbolo di un mondo migliore!
Concludo riaffermando la validità sul piano poetico, civile e morale delle liriche di Ferrari, che contengono sia il ricordo (di un mondo che non possiamo dimenticare), sia il progetto per un mondo migliore verso cui tutti dobbiamo tendere e in cui domini l’essere e non l’aver, il bene di tutti e non l’egoismo! Mi piacerebbe concludere con i versi del nostro Giannino, tratti da “La barca delle fate”. La fanciulla innamorata non si perde d’animo, ma prega, implora e con la forza del suo grande amore riesce a riportare sulla giusta via l’innamorato che ritorna a lei.
Da “La barca delle fate”:
E l’uomo tornò
E si lavò la faccia col suo pianto
E bacio la rosa profumata
(che “lei” aveva raccolto nel giardino,
rossa come il fuoco del suo cuore)
E bevve l’acqua della fontana delle fate
E rimase con lei per sempre
Con lei che sola vide la barca delle fate.